di Simone Giraudi.
Capitolo I Capitolo VI
Capitolo II
Capitolo III
Capitolo IV
Capitolo V
La casa di Ester, questo è il nome della madre di Giacomo, non è molto lontana dalla piazza dei “XXX Martiri”. Uscendo dallo studio imbocchiamo la strada principale in discesa giungendo a un’altra apertura con un fontanone e una chiesa, distanziati tra loro da un cortile e circondati da palazzine. È passata l’una e mezza e il paese è in ibernazione fino alla prossima alba. Oltre a noi due, in giro, non c’è nessuno. Guardo Giacomo. In lui non c’è traccia dell’uomo spaventato di questa mattina e, stretto nel cappotto, aggredisce la notte ad ampie falcate; tiene le braccia immobili lungo i fianchi e le mani chiuse a pugno, come un abnorme soldatino di piombo.
Ci addentriamo nella piazza e spiego a Giacomo quel che farò in concreto con sua madre, cioè una delle tecniche d’interrogatorio che preferisco. Infallibile e senza pericoli per la signora, perfetta per l’occasione. Voglio che sia ben chiaro: sarò io a fare le domande e lui dovrà parlare il meno possibile. Questa è la nostra migliore occasione per capire dove si nasconde l’Incubus, non possiamo lasciarcela sfuggire. Lui annuisce e basta. Voglio prenderlo come un segnale positivo.
Una targa con scritto Casa Prieri campeggia sulla parete color dentifricio di una delle palazzine, vicina a un portone ad arco che ci accoglie come il volto di una strana creatura. Le finestre del piano terra schermate dalle inferriate e quelle del secondo piano con le imposte chiuse sembrano una manciata di palpebre abbassate e di bocche socchiuse. Giacomo tira un sospiro e preme sul campanello del citofono, ha il respiro affannoso e batte ritmicamente un piede sull’asfalto. Dopo
qualche minuto sentiamo dei passi affettati. Il portone si apre e ci si para davanti una bella donna, bassa e pallida, con una vestaglia blu senza maniche, lunghi capelli castani e, dietro gli occhiali, gli occhi verde marcio. L’accompagna l’odore di fumo e non sembra avere più di sessantacinque anni.
Gli occhi della donna si piazzano subito su Giacomo e mi rendo conto che, dentro, sembra non esserci niente. Forse siamo sulla strada giusta, anche se potrebbe essere dovuto al risveglio improvviso. Seppur incomparabili fisicamente, Giacomo somiglia a Ester molto più che a Roberto.
«Ci fai entrare o no?» le chiede lui.
«Questo chi è?» chiede Ester con la voce affaticata tipica di chi ha la nicotina come amante da parecchio tempo.
«Un amico. Dobbiamo parlarti» risponde Giacomo, attraversando l’uscio senza aspettare un invito. Io lo seguo, subito dopo.
Oltre il portone si apre un cortile di cemento che ospita una vecchia Fiat Uno coperta con un telo picchiettato di brina. Il cortile conduce ai due piani del palazzo, o almeno dovrebbe: la scalinata per quello superiore è bloccata da un cancelletto in ferro. Ester ci precede verso una porta incassata sotto la scalinata. Lei e Giacomo camminano allo stesso modo ma lui ha gli occhi bassi, come se cercasse di costringersi a non guardarsi attorno.
Entriamo in un salotto fermo agli anni Cinquanta con due librerie di legno, un divano ocra vomitevole e una poltrona di pelle molto bassa davanti a un tavolino di vetro ovale. Le pareti, coperte da vecchia carta da parati, sono tappezzate di quadri con dentro fotografie di Poràgneve in bianco e nero. Tutto profuma di un misto tra disinfettante per parquet e fumo passivo: sul tavolino ci sono un posacenere stracolmo, un accendino e un pacchetto di sigarette aperto. Ester ci invita sul divano con un gesto della mano. Mi siedo in corrispondenza del posacenere e Giacomo dall’altro lato, il più lontano possibile da lei.
«Allora? Che volete?» chiede lei a un certo punto, prendendo sigaretta e accendino e mettendosi a fumare.
Giacomo mi guarda. «Ester, ti piacciono i trucchi di magia?»
«Ci conosciamo da tre minuti. Il “tu” è un po’ troppo informale».
«Vacci piano – mi dice Giacomo sistemandosi sul divano – . Credo abbia dato del “tu” a mio padre solo dopo il quinto appuntamento”.
Ester gli lancia un’occhiataccia.
«Non ti piacciono? Perché ne conosco un paio».
Silenzio.
«Vorrei fartene vedere uno».
Silenzio.
Prendo dal posacenere uno dei mozziconi ingialliti e picchietto il filtro sulla lingua. Poi lo faccio con altri due mozziconi e li metto sulla superficie di vetro del tavolino. Ester mi guarda, continuando a fumare, e Giacomo segue i miei movimenti senza fiatare.
«Ecco. Ora, se non dovessi rispondere alle mie domande con la verità, i mozziconi prenderanno fuoco da soli».
Silenzio.
«Proviamo. Sei nata e hai sempre vissuto a Poràgneve?»
Lei tira una lenta boccata di fumo prima di rispondere. «No».
Il primo dei mozziconi viene avvolto da una fiammata improvvisa, accartocciandosi in pochi istanti. Ester sobbalza, la bocca aperta e la sigaretta tra le dita secche, poi guarda il mozzicone disintegrarsi in cenere nera senza che il calore lasci traccia sul vetro del tavolino.
«Che razza di amico è questo?» dice Ester rivolta al figlio.
«Non uno di quelli che vorresti far conoscere alla mamma – dico – . E comunque le domande le faccio io. Giacomo mi ha detto che c’eri, all’arrivo dei nazisti. Quanti anni avevi?»
«Quasi tredici».
Nessun mozzicone in fiamme.
«Sei l’ultima rimasta a Poràgneve ad aver assistito in prima persona a quegli eventi?»
«L’unica ancora viva o fuori dalle case di cura, sì».
Mozziconi ancora intatti.
«Cosa ricordi di quel giorno? Dopo il massacro, che hai fatto?»
«Ricordo tutto, specie quando mi guardo allo specchio. I miei occhi sono… così da quella mattina. Comunque, nella calca sono stata sbattuta contro il porticato del municipio. I nazisti hanno fatto quel che dovevano e poi, quando se ne sono andati e anche se era molto tardi, abbiamo portato i morti al camposanto per il riconoscimento. Li abbiamo lasciati in camera mortuaria e il giorno dopo è venuto il Vescovo per la benedizione”.
Il secondo mozzicone esplode in una vampata di fiamme.
«E va bene, io non sono andata al cimitero, sono rimasta in paese».
«E lì che cosa è successo?»
«Che vuoi dire?»
«Hai incontrato qualcuno o qualcosa?» le chiedo lanciando un’occhiata a Giacomo, che guarda Ester con gli occhi iniettati di sangue. «Come un minuscolo cavallo bianco volante, grosso quanto un moscone?»
Ester mi guarda, in silenzio, con gli occhi stretti e sospettosi. «Che cosa volete da me, davvero?»
Prima che possa dire qualcosa Giacomo si alza battendo un pugno su uno dei braccioli del divano. Ester sobbalza di nuovo, spaventata. E questa volta anche io.
«Cristo! Sappiamo tutto dell’Incubus!»
Beh, ha avuto più autocontrollo di quanto mi aspettassi.
«Non riuscivi a sopportare che avessi lasciato questo posto insignificante, e hai deciso di tormentarmi con… quella cosa! Perché è questo che sei, una creatura malvagia, chiusa nell’unico posto in cui si sente al sicuro e troppo sola per pensare che ci sia qualcosa al di fuori!»
Ester guarda il figlio con le labbra strette. Somiglia a un alligatore pronto a serrare le mandibole sulla preda. «Torni a casa per la prima volta da anni solo per aggredirmi? Che cosa vuoi? Cosa volete?»
«Sappiamo tutto, puoi solo esserci tu dietro!»
«Non ho idea di cosa tu stia parlando!»
«Non sarei mai tornato se non avessi mandato l’Incubus… e per cosa, poi? Per punirmi? Giuro, vorrei essere sorpreso, ma non lo sono. È proprio da te. Pensavo che mandare papà all’altro mondo ti fosse bastato!»
Nel salotto cala il silenzio. Giacomo ed Ester, lui in piedi e lei ancora seduta sulla poltrona, si guardano fissi con i volti lividi di rabbia e sembrano due sacchi di iuta vuoti. È Ester a spezzare il silenzio per prima, con la voce sussurrata. «Vattene via. E portati questo “amico” e le sue domande assurde. Non so cosa pensavate di fare ma non ti ho chiesto io di tornare. Per me, mio figlio è morto insieme a mio marito».
Con un ruggito, anche il terzo mozzicone esplode in fiamme.
«Vediamo di darci tutti una calmata, ok? – dico, passandomi una mano sul cranio pelato e prendendo un lungo respiro – Se riusciste a togliervi la testa dal buco del culo per la prima volta in vent’anni magari potremmo risolvere qualcosa!»
In tutta risposta Ester si alza dalla poltrona e spegne la sigaretta nel posacenere. Poi sparisce in un’altra stanza, tornando con una paletta e una scopetta, con le quali raccoglie i resti dei tre mozziconi consumati. «Va’ avanti» mi dice, tornando a sedersi sulla poltrona.
Inizio spiegandole chi diavolo sono e cosa ci faccio non tanto qui a casa sua, ma così lontano dalla mia. Ester ascolta senza interrompermi. Giacomo, invece, sprofonda nella sua parte di divano fissando il soffitto.
«Ho scoperto che in paese si nasconde un Incubus. Sono piccoli bastardi che si legano agli esseri umani e si nutrono delle loro emozioni negative. Solo che questo qui non è piccolo, e fa cose strane come continuare a infestare la sfera emotiva di qualcuno che se ne sta in Germania per decenni».
«Ed è strano?»
«Gli Incubus sono territoriali: non si avventurano a chilometri dall’ospite principale, figuriamoci da uno stato all’altro».
Ester ci guarda in silenzio, tutti e due. «E pensate che io abbia mandato quella… cosa contro il mio unico figlio?»
«Se nemmeno tu controlli l’Incubus allora nessuno lo sta facendo – le dico – . Ma tu rimani l’ospite principale, la sua fonte di nutrimento più importante. È arrivato qui il giorno dell’eccidio quindi te lo chiedo di nuovo: che cosa hai fatto dopo l’arrivo dei nazisti?».
Ester risponde, lo sguardo fisso sul posacenere. «Mentre il resto del paese era al cimitero io sono andata vicino al vecchio convento domenicano, dalla parte esattamente opposta. Lì mi sono accorta di avere attorno una creaturina minuscola, che sembrava parlarmi… ho sempre pensato fosse stata un’allucinazione. Ascoltarla non mi è sembrato così assurdo come quello a cui avevo appena assistito».
«Che ti diceva?».
«Ricordo poco ma la sua voce mi è rimasta in testa, assieme alle immagini di quel giorno: era simile allo strappo del legno di un albero che cade. Non credo parlò mai dell’eccidio, solo di come sarebbe stata la mia vita da lì in avanti. Poi, ho sentito la mia anima ripulirsi, sgrassarsi. Come se ogni pensiero negativo mi fosse stato raschiato via dal cuore».
«Di che stiamo parlando?» sbotta Giacomo interrompendola.
«Che vuoi dire?»
«La mia infestazione. Il super Incubus ha fatto tutto da solo?»
«È legato alla persona con cui hai passato più tempo, in passato. Probabilmente quel frammento te lo porti dietro sin dalla nascita».
«Già. E perché ha continuato a funzionare anche in Germania? E perché i sogni sono iniziati solo adesso?»
«Le domande sono ancora tante, ma…»
«Quindi non siamo più vicini a risolvere nulla!» m’interrompe lui alzando di nuovo la voce e uscendo dal salotto.
Non ho il tempo di rispondergli e va bene così. Ha ragione, procediamo a piccoli passi, ma non serve abbaiarci contro.
Anche Ester è rimasta sulla poltrona. Fissa una delle vecchie fotografie di Poràgneve appesa alla parete dietro il divano, e non dice nulla. Non è facile scoprire di essere la causa del crollo nervoso di un figlio che non vedevi da vent’anni. Dopo un po’ si accende un’altra sigaretta.
«Ester, che cosa ti è successo un mese fa?»
«Che vuoi dire?»
«I sogni di Giacomo sono iniziati allora e qualcosa deve averli fatti scattare».
Da lei, subito silenzio, di nuovo. Poi: «Ho scoperto di avere un cancro. Terminale. Quadra?»
Potrebbe. Il frammento dentro Giacomo li mette in contatto e una notizia di questo tipo ha avuto di sicuro un riverbero nella sfera emotiva di Ester e dell’Incubus.
«Quanto ti resta?»
«Chi può dirlo?»
«Deve saperlo» le dico, rendendomi conto di non avere alcun diritto di farlo. Ester rimane immobile. Mi aspetto che prenda a urlare e invece chiude gli occhi ed espira il fumo della sigaretta verso il soffitto. «Sì, credo di sì».
Ester finisce la sigaretta e la aggiunge alle altre nel posacenere poi rimane sulla poltrona con la testa bassa. Piange, senza emettere alcun suono. Come se l’atto di versare lacrime fosse sacro e prezioso, troppo intimo perché le altre persone possano accorgersene. «Roberto lo diceva sempre, “Quella roba ti ammazzerà, un giorno” – aggiunge – . Lui non aveva mai fatto nemmeno un tiro. Senti, puoi prenderlo a calci questo… Incubus?»
«È quello che voglio fare».
«E allora fallo».
Mi alzo e lascio il soggiorno uscendo all’esterno. Trovo Giacomo seduto sui gradini della scalinata, con le braccia strette sotto le ginocchia. Sta morendo di freddo. Mi fermo davanti a lui e prendo un chewing-gum da dentro la giacca.
«Che facciamo adesso?» mi chiede.
«Come si arriva al posto in cui tua madre ha incontrato l’Incubus per la prima volta?»
«Piazza San Domenico? Basta seguire fino alla fine la strada a sinistra della piazza. Il vecchio convento ora è una casa privata, ci fanno scavi archeologici. Davanti c’è una piazzetta con le giostre. Perché?»
«È lì che si nasconde».
Giacomo sbarra gli occhi, la condensa gli esce dalla bocca semi aperta. «Andiamoci subito!»
«Tu non vieni».
«Cosa?»
«Non vuoi esserci sul serio. E soprattutto non voglio io: quello è un vero bastardo, se voglio fotterlo non posso dover pensare prima alla tua incolumità che alla mia».
Ancora una volta dirgli che non sono sicuro il mio approccio “testa bassa e caricare” finirà davvero per funzionare, sarebbe troppo lungo. Se c’è una cosa che l’Incubus non si aspetta è che vada da lui, forse non immagina nemmeno che ho trovato l’ospite principale. Ma questo non significa che accetterà di andarsene a fanculo senza fiatare.
Giacomo si prende un paio di secondi per pensarci, poi tira un sospiro e annuisce, rimettendosi in piedi. «Hai ragione. Posso chiederti una cosa?»
«Vai».
«Tutti i problemi della nostra famiglia. Credi che, senza l’Incubus, avremmo potuto avere una vita diversa? Io, mio padre, mia… Ester, saremmo stati qualcos’altro?»
Ha ancora bisogno di un colpevole. Sono domande sensate, ma a cui non posso dare una risposta.
«Vai dentro» gli dico, stringendomi nella giacca.
«Mi sto abituando al freddo, sai?» mente lui, tremando.
«Amico… vai dentro».
Cammino a passi lenti verso il portone, tiro il chiavistello e lo apro facendolo scricchiolare nel buio. «Mandalo a fanculo anche da parte mia» mi dice Giacomo da dietro le spalle.
Da quando li ho visti insieme per la prima volta non mi è mai sembrato così simile a sua madre.
Simone Giraudi è un giornalista e vive a Peveragno (CN). Adora raccontare e farsi raccontare storie, il cioccolato fondente e David Hasselhoff. Ha frequentato il corso di sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics di Torino.
Scrive dal 2012: ha autopubblicato due libri (una raccolta di racconti horror e un racconto lungo di fantascienza) e nel 2017, con Leucotea Edizioni, il romanzo “Tatuaggi Color Pelle”. Dal 2018 scrive per lo più racconti; si possono trovare nelle raccolte di fantascienza “Prisma” e “HUMAN/” (entrambi Moscabianca edizioni) e sulle riviste Spore, Salmace, Blam, Quaerere, Enne2Rivista e Altri Animali. Un suo racconto è menzione speciale nel concorso ‘Da un’illustrazione a una storia’, realizzato da Rivista Blam assieme ad Antonio Pronostico.
Immagine: Claudia Corso (@aetnensis), 1997, illustratrice, viaggia nello spazio e nel tempo libero studia Arti Visive a Bologna. Le piacciono i robot, la fantascienza e gli abbinamenti di colori improbabili.
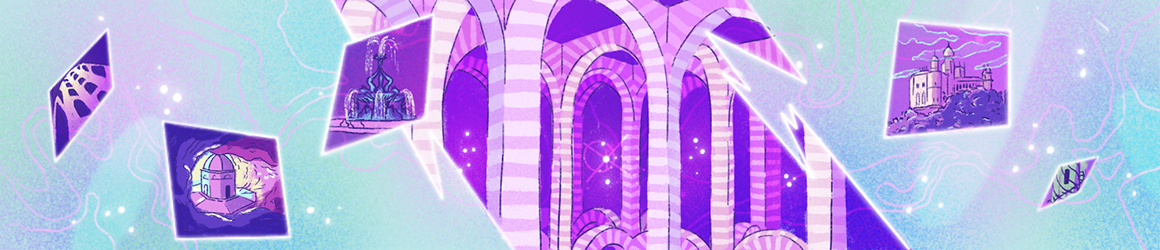

2 pensieri riguardo “Capitolo VII / L’ospite”