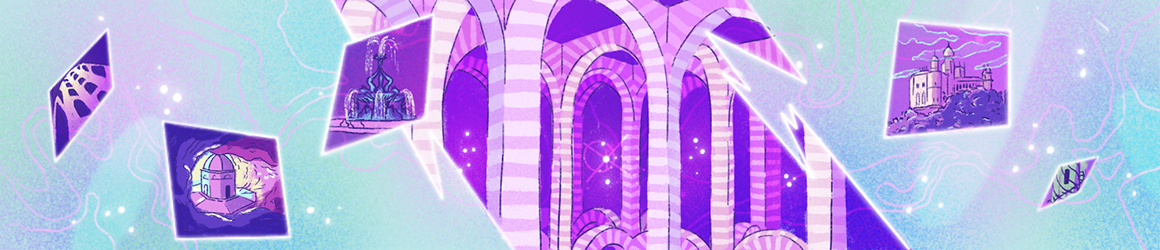di Nicole Trevisan.
Orto botanico è la rubrica di Spore in cui esploriamo nuove zone incontaminate ma sicuramente ricchissime. Esordi, storie di autorə mai lettə prima da queste parti.
Simile a colui che vuole afferrare l’ombra o inseguire il vento è colui che dà credito ai sogni. Chi sogna è come se si ponesse di fronte a sé stesso: davanti al volto ha l’immagine di uno specchio. Da fonte impura può scaturire cosa pura? E da menzogna, può scaturire verità? Son cose vane, divinazione, auspici, sogni: ciò che speri, ecco ciò che sogni. Se non è l’altissimo che li manda a visitarti, non far caso ai sogni.
Ecclesiastico, 34, 1-6.
Il divino è simmetrico. Uno, trino scorporato in Padre, Figlio, Spirito Santo; dodici è apostolico pitagorico: la nostra fede brucia in terzine di candele, in aureole di santi, è geometria di stelle fisse in cima alla cupola di San Gregorio dell’Albayzìn. Altrove si muovono. Fuori dalle nostre celle è resa al caos e alle orbite ellittiche in approssimazione, i fuochi sono altri astri inquieti, ovunque è canto notturno e muto di armonie da aggiornare ogni anno che passa. Noi, restiamo.
L’altare è il centro della terra e lo vegliamo a turno.
Siamo quattro, bianche quanto le mura del convento, l’intonaco delle case gitane che erano arabe e il sole oltre le grate. Ricordo poco delle strade, la memoria è una scelta e quando sono entrata, straniera più che bambina, ho capito che Nostra Signora mi avrebbe protetta in cambio del tempo e dello spazio offertomi dal mondo. Mi avrebbe accompagnata verso il sonno eterno con ricordi puri, sfoltiti di quel che era stato perché la fede prendesse posto, allontanando il pensiero dai sentieri delle cose passate: sarebbero sfumate, radici e fronde e piogge ne avrebbero sciacquato i contorni fino a cancellarle.
Sono nata qui, Maria Inés, esclava del Santisimo Sacramento y de la Inmaculada – il nome che portavo prima ha smesso di esistere e non c’è bocca che lo nomini né lo ricordi. Se lo leggessi o sentissi, non saprei riconoscerlo.
Credo sia accaduto anche alle mie consorelle, non ne parliamo: siamo votate al Silenzio, i volti hanno imparato a tacere, si sono dipinti dei medesimi toni, su uniformi equilibri di luce e ombra. Possiamo cantare e rendere grazie, pregare e lodare. La voce ci è stata lasciata dentro a labbra che si assottigliano e anneriscono. Lungo le gole soffocate dai colletti, conserviamo la radice di un’individualità. Noi siamo la nostra voce e la voce è dedicata a Dio.
Preghiamo una per volta all’altare; le altre restano sedute. Chi entra nella cappella ci scambia per spettri. Immobili, non ascoltiamo, dimentichiamo.
Un mattino, ho sentito un piede appuntarmi a terra l’orlo del velo. Uno strattone lo ha fatto risalire scoprendomi la fronte, spogliandomi gli occhi e, compiendo peccato, mi sono voltata. Le mie sorelle stavano leggendo i salmi e suor Adriana cogliendo la torsione del collo all’indietro, mi ha rimproverata. Non c’era nessuno oltre la grata dietro di me, nemmeno i passi di qualcuno che fugge. Tornata a mani giunte dietro lo strato fumoso che mi copriva fino alla punta del naso, ho atteso la spiegazione di quello scherzo, un appiglio divino o logico. Distratta non pregai, accorgendomi che dalle strade non risaliva alcun rumore: dovevano essere vuote. Ho provato a immaginarle, peccando due volte, tre quando ho ceduto alla curiosità, cercando ai margini del velo un’impronta di scarpa che non c’era.
Prima delle nove di sera, cala il grande Silenzio. Possiamo sentire la polvere depositarsi negli intarsi delle icone, nelle pieghe delle vesti della Madonna e del Bambino e soffocarne l’oro, richiamandoci al dovere del giorno dopo: pulizia, servizio, abnegazione. I nostri passi si sono alleggeriti nel tempo, sono schiuma sopra le onde; fuori, la città ribolle del calore accumulato e le nostre mura si gonfiano dei sospiri della pietra, ansiosa di riposo.
Provo anche io quella notte, ma sento il sudore tra le costole e con esso il mio corpo, arrivando a quattro con la conta dei peccati. Decido di consacrare allora il sonno al pentimento sgranando preghiere fino a poco prima delle Odi del mattino.
Sogno. Mi vedo camminare lungo una salita, scalando il fianco arido di una montagna con qualcuno che devo aver conosciuto, da cui scappo ridendo, correndo verso una casa che è un rammendo inconscio tra la mia cella, la mensa e i labirinti della cripta di San Gregorio. Dentro c’è un ragazzo. Ha occhi marci, un verde di pelle di lucertola che non ho creato, forse era stato reale, un giorno, da qualche parte; mi segue o attende, apro la bocca per chiedere e scopro di non essere vestita di bianco, di non avere voce, mi spavento e mi ritrovo nel etto senza risposte per non essere riuscita a fare domande.
Lavoro a lungo nell’orto, fiaccandomi per espiare e sperando in un sonno che mi precipiti in strati più densi, dove le immagini si fondono e ogni dimensione si svuota, scivolando via dai ganci della memoria. Vengo accontentata, la seconda notte non accadde nulla.
La terza, tuttavia, torno tra quelle montagne e una piccola mano stringe la mia, mi guida e sembra non volermi lasciare, malgrado il sudore ci scolli i palmi e manchi il respiro per la fatica. Le gambe mi tremano, la luce cade a picco e intorno tutto sembra fatto di ghiaccio. Ho l’impressione di muovermi in un tempo inventato, in cui Dio non esiste e al mondo siamo in due, bambini erranti senza origine, inizio e fine di ogni cosa, a sbrogliare infinite catene di montagne con la vergogna di tenerci vicini. Lui mi chiede se posso camminare ancora: la sua voce mi sfugge, liquida, e non la ritrovo al risveglio.
Aggiungo una preghiera, cedendo al mio egoismo, per addormentarmi e raggiungere quelle persone di cui non ricordo l’aspetto né so il nome. Voglio accanto il ragazzino, anche solo un istante nell’intera estensione del sonno, un grano d’irrealtà che mi è concessa per avvicinarmi a quel che è stato, dimenticato o mai esistito, che rompe il silenzio e mi consola nella forma e nella sostanza di un essere umano. Non era un’entità divina e onnipotente, era fragile e fallibile; non una Sorella, astratta per farsi serva, era una presenza viva, col vizio di non essere.
Mi crogiolo nel segreto dei miei peccati, cercandomi ogni mattina la croce al collo, accertandomi che nello spasmo di libertà onirica non me la sono strappata di dosso.
– Padre, ho peccato.
– Confessa.
– Sto sognando.
– Cara Sorella, non abbiamo potere sui luoghi e le immagini che visitiamo nel sonno. Prega, affinché Nostra Signora allontani le tentazioni e le blasfemie dalla tua mente.
– Ho la mia parte di colpa. Io desidero sognare.
– Desiderare è peccato.
– Lo so.
– E nei sogni, cosa ti spinge a corromperti?
– Mi vedo fuori dal monastero. Molto piccola o come appaio adesso. C’è qualcuno con me. Sconosciuti, non conosco i loro nomi. È come se sapessero ogni cosa di me. Alcuni non sono gentili, ma uno di loro mi aiuta, mi consola se ho paura.
Non vedo il volto del prete oltre lo schermo del confessionale, la sua pausa mi restituisce perplessità, la risata muta per l’ingenuità di noi suore, razza mutilata di femmina, inoffensive.
– È tutto?
Ha giunto le mani. Le spinge contro l’intreccio di ferro che ci separa e noto gli anelli.
– Sì.
Obbedienza, umiltà, accettazione.
– Chi ti appare, potrebbe essere Dio stesso in una forma che ti rassicura. Niente di più puro di un bambino. Forse un fratello o un amico che ti era vicino quando eri piccola. Egli non ti abbandona e ti assiste in tutte le prove della vita. Da quanto non esci, suor Maria Inès?
Mi affretto ad annuire, senza rispondere. Lui se ne accorge, preferisce non insistere. Lo annoiamo. Lui può camminare per le strade e parlare con chiunque ne abbia voglia e attinga a una vita con dimensioni più profonde delle nostre, recluse in una sequenza di gesti.
– Deve essere come dice lei.
– Il tuo ordine incoraggia il distacco, ma rinnegare ciò che è stato è pericoloso. Capisci?
– Credo di sì, Padre.
– Siamo attratti dalle consolazioni personali. Alla tua età, i ricordi non sono più una tentazione. La tua anima non è in pericolo. Pregherai e chiederai perdono per aver desiderato. Ora, recita con me.
Il buio del confessionale mischia la vernice ripassata sul legno con il fiato dolciastro del prete e sotto strati di velo, la mia testa oscilla in negazione, pur scandendo a mente e a parole i termini del perdono. Vortica mancando il centro, l’equilibrio. Riesco a trascinarmi al sicuro nella navata, dove i fumi d’incenso soffocano gli angeli intorno all’oculo della cupola. Da quel foro piove un po’ di sole, mi benedice bagnandomi il capo. Un effetto dell’astro, matematica applicata al divino.
Con quella chiazza che mi scava le guance mi perdo nella fisionomia della Madonna, cerata e incoronata. Sorretta da un’impalcatura di velluti, scorgo un certo compiacimento nella sua distante serenità. Mi è nuovo. Il sorriso in lacca rossa è allusivo. Irritante. Tanto che mi alzo dalla panca ed esco sbattendo la porta, infangandomi in un vicolo disseminato di schiamazzi sotto la perplessità delle donne arabe che sollevano le serrande dei negozi.
Scendo, anziché salire verso San Nicola e il Sacromonte, sotto i drappi tesi tra i balconi e le insegne delle osterie, inciampando e incastrando le suole dei sandali tra i ciottoli, dannandomi nell’abbaglio del giorno. Raggiungo un caffè, prendo posto senza sapere come pagare. Non ho niente e non sono in grado di esercitare qualche forma di pietismo comportandomi da donna anziana, consacrata e confusa.
I camerieri mi ignorarono, lasciandomi tra i piccioni che si affollano tra i tavolini apparecchiati dei resti della colazione. Beccano tovagliolini, immergono le teste in tazze vuote. Poi, si avvicina un uomo.
– Ce l’hai fatta, alla fine.
– Chi sei?
Parlo senza cantare né onorare, per la prima volta da quando mi hanno tagliato i capelli e infilata in un abito bianco che non avevo mai smesso. Lui limita il sorriso a un mezzo dispiacere e lo riconosco. Non è più un bambino. Mi siede accanto.
– Dicevano che ne saresti uscita solo da morta.
– Un’altra promessa mancata. Chi sei?
– Non ti senti in colpa? Per essere uscita così, d’impeto. Senza un soldo, neanche una moneta o un fazzoletto. Non è da te, eri precisa, pensierosa sin da quando ti esercitavi a scrivere il tuo nome. A terra, tracciando le lettere con una spiga. Quanti anni sono passati?
Ha un arrochimento assonnato e fluido, da fumatore precoce. Sento di averlo ascoltato a lungo nei miei anni di veglia, oltre che nel sonno. Mi aggrappo con le mani al velo, tirandolo sulle orecchie, prendendomela con la sordità della memoria.
– Non ricordo.
– Io sì, Agustina.
– Mi sorvegliavi.
– Ti ho cercato, sì. Nessuno sapeva dove ti avessero portata. In Europa, dicevano, come se fosse una città e non un intero continente. Ci è voluto un po’ per raggiungerti, ho fatto domande. I vecchi parlano più volentieri quando sanno di essere sul punto di morire, te ne sarai accorta. Tuo padre mi ha implorato di perdonarlo, l’ha fatto per il tuo bene, ha detto. Anche il suo, si è risposato, ha avuto altri figli.
– Mio padre. I miei fratelli…
– Noi non lo eravamo, se questo può aiutarti a ricordare.
– Non erano buoni con me.
– No, e io ero troppo giovane per essere un’alternativa a quello che sei diventata. Mi dispiace.
Proietta un’ombra sul tavolino, mi si allarga sui vestiti in un grigiore umido che mi si appiccica addosso, facendomi sentire freddo nel fondo della sua colpa. Non c’è rimedio e lo sa, per questo è affranto. E lo sono anche io.
– È passato troppo tempo.
Cerco un responsabile oggettivo.
– Volevo vederti, sapere che stessi bene. Voi Esclave de la Inmaculada, però, non potete girarvi verso i fedeli e sapere che ero lì con te. L’hai fatto una volta, è stata l’ultima.
Mi tende la mano, la riconosco anche se è nervosa, tiepida e morbida come la pelle delle lucertole e il colore dei suoi occhi: devono esserci stati giorni passati a rincorrerle o che loro hanno trascorso immobili a guardarci. Scopro che è un pensiero già fatto, l’ho conservato fino a questo momento.
La nostalgia esplode dal petto alla punta delle dita, lo fermo con le unghie sulla superficie del tavolino, tra una scacchiera di tazzine che non faccio cadere. Vede la mia tristezza. Ed è troppo tardi.
– Non sono riuscita a vederti, Enrique.
La Madonna dell’Aurora, stella prima del mattino, ha braccia soffocate in maniche di broccato. Non esistono, non ci accolgono e noi non alziamo lo sguardo su di lei. Siedo a una delle panche, sarò la prossima a inginocchiarsi all’altare. Dietro, scattano fotografie. Siamo zimbelli turistici, ci siamo cavate gli occhi per non vedere né questo né Nostra Signora; sentiamo, sospese come cenere sulla sostanza mutevole del tempo, siamo esseri tattili e semi muti.
Sogno ancora Enrique. Ogni tanto, entra e prende posto in fondo, oltre la grata. Non ho bisogno di voltarmi per riconoscerlo. La memoria è un sentiero a cui strappare le erbacce e il ritorno segue le vecchie impronte. Non ha mai voluto portarmi via, mi sapeva al sicuro e che avrei ricordato, un giorno, che mi voltassi o no. Controllava che respirassi dal minimo movimento del velo, che almeno mi restasse la voce. Mi trova ancora, anche se non può vedermi e ho smesso di esistere per farmi congettura, teoria, anima, uno di due, due che è dannazione. E simmetria.
Nicole Trevisan è nata e lavora in Veneto nel settore dell’architettura e della progettazione. Affascinata dalle cose morte e dal tema del trapasso, ha scritto racconti che sono stati pubblicati su Nuova Carne, malgrado le mosche, Spaghetti Writers, Bomarscé, Blam, Quaerere, Narrandom e Turchese. Nel 2022 si è classificata seconda al concorso Mensa in fabula; nell’edizione dello stesso anno del premio Zeno, è finalista nella sezione racconti brevi.
Immagine: Valentina Ramacciotti.