di Matteo Romano.
Orto botanico è la rubrica di Spore in cui esploriamo nuove zone incontaminate ma sicuramente ricchissime. Esordi, storie di autorə mai lettə prima da queste parti.
Mio padre Alfredo già presentiva quando gli sarebbero cresciute le ossa. Ma di questo ce ne accorgevamo anche noi. Io e la mia famiglia, intendo. Papà diveniva cupo e taciturno, irritabile alla minima sciocchezza. Una volta tirò la zuppa di farro ancora bollente addosso a mia madre, perché secondo lui era immangiabile. Spesso gli veniva una febbricola per qualche giorno, così mio fratello Biagio e io dovevamo sbrigarcela da soli col lavoro in falegnameria.
L’aveva afflitto per tutta la vita, ed era davvero una strana malattia la sua, di quelle che non s’erano mai viste prima. Era pieno di cicatrici, papà. Le ossa si allungavano, gli spuntavano in qualsiasi parte del corpo forandogli la carne. Gli crescevano la notte. Potevano essere le falangi delle mani o dei piedi, il ginocchio, uno zigomo. Assumeva un aspetto impressionante, da far rizzare i peli. Di solito le ossa se le segava da solo, ma se per caso si trattava di una vertebra aveva bisogno per forza di me o di Biagio. Non lo davo mai a vedere, ma lo stridio delle ossa segate mi rabbrividiva. Le schegge, quella finissima polvere bianca. Mi si torcevano le viscere. Quel rumore lo sento vorticare ancora in testa, come un ronzio.
Una volta gli si allungò il coccige. La mia sorellina Marta scoppiò a ridere perché le sembrava una coda, così mio padre la prese a cinghiate. Se non lo avessimo fermato l’avrebbe di sicuro ammazzata. Mamma piangeva tenendosi Marta in braccio.
Mio padre conservava tutte le ossa vecchie in un sacco nascosto nella falegnameria accanto a casa nostra. Non era un segreto per noi. Le nuove se le portava dietro per farle esaminare dal dottor Tassi. Quello ponderava il mucchio in silenzio, dopodiché medicava le ferite di mio padre, profondi e irritati fori rossi, e lo confortava dicendogli che prima o poi avrebbe scoperto la causa di quel malanno e trovato una cura. Ma l’espressione fin troppo quieta sul suo viso, mi fece intuire che non ne sarebbe mai venuto a capo. Gli raccomandò di evitare il latte, i formaggi, e di ridurre i legumi, ma questo era impossibile, dato che in paese ci nutrivamo solo di quelli. Sulla strada di casa, papà bestemmiava il dottore digrignando. Sosteneva fosse un mentecatto che gli rubava solo soldi, e non aveva torto.
Io e Biagio temevamo potesse essere una di quelle malattie che si trasmettono di padre in figlio per colpa del sangue, ma grazie a Dio nessuno in casa aveva mai mostrato sintomi del genere. Marta, a differenza nostra, non sembrava preoccupata dallo stato di salute di nostro padre. Forse era troppo piccola per rendersi conto della gravità della situazione. Spesso, quando segavamo le ossa, Marta ci sorvegliava, ci spiava con quella curiosità tipica dei bambini. Se papà se ne accorgeva le urlava di sparire. Allora arrivava mia madre, l’afferrava per l’orecchio e la trascinava via fra strilli e pianti.
Un pomeriggio notai Marta sgattaiolare fuori di casa. La seguii e la vidi intrufolarsi nella falegnameria dal retro. Mi accostai alla finestra: se ne stava seduta sul pavimento, acquattata. Entrai di colpo e Marta si voltò: di fronte a lei c’era il sacco, e in mano teneva un probabile frammento di tibia. Scattò in piedi terrorizzata. Le chiesi cosa stesse combinando; rispose che voleva soltanto guardare le ossa da vicino, scoprire com’erano fatte. Mi scongiurò di non spifferarlo a nostro padre. La rassicurai promettendole che avrei mantenuto il segreto. Poi, le ordinai di rimettere tutto nel sacco, di non toccarlo mai più, per nessun motivo, anzi di dimenticarselo. Glielo feci giurare per tre volte.
Qualche giorno dopo, mentre lavoravo, udii mamma sgridare Marta. Papà comandò di andare a controllare. Una volta in casa vidi mia madre strapparle di mano una pala. Mia sorella aveva lo sguardo basso e le mani sporche di terra, in una stringeva l’annaffiatoio. Strattonandola, mamma la torchiò per sapere a cosa le fosse servita. Marta rispose che ci aveva giocato in giardino, che non aveva fatto niente di male. Dissi a mia madre di non rimproverarla per qualsiasi cosa, che in fondo era solo una bambina. Accarezzai Marta. Nel giardino la terra era stata smossa in un punto vicino alla falegnameria.
In quel periodo lavoravamo senza sosta. Stavamo realizzando i mobili per la nuova casa dell’avvocato. Utilizzavamo solo legno in noce, andavamo noi stessi nel bosco per abbattere gli alberi migliori. Mio padre ne soppesava uno e poi ci ordinava di tagliarlo. I nostri erano lavori sopraffini, intarsi e altre decorazioni da lasciare a bocca aperta. I clienti venivano anche dai paesi attorno. Papà era un maestro d’ascia formidabile.
Era inverno. Il freddo s’impadroniva della casa costringendo mia madre a gettare legna di continuo nella stufa. Pioveva. Eravamo seduti a tavola, con la minestra fumante sotto al naso, e attendevamo mio padre per cenare. Nonostante lo scosciare dell’acqua, dalla falegnameria arrivava un intenso trambusto. Mio padre imprecava.
Poi irruppe in casa sbattendosi dietro la porta. Era inzuppato, ansava, ci scoccava sguardi fulminei e allucinati. Urlando, ci chiedeva che fine aveva fatto il suo sacco, chi l’aveva preso. Di sottecchi vidi Marta tremare, il viso circonfuso dal vapore della minestra. Io e mia madre ci scambiammo una breve occhiata. Nessuno fiatava, allora mio padre s’imbestialì ancora di più. Sbraitò come un pazzo, schiantando la sedia contro il muro. Mia madre si era tappata la bocca, Biagio era inebetito.
A un tratto esclamai che l’avevo sotterrato in giardino. Lui s’avvicinò a muso duro. Aveva le fiamme negli occhi. Mi chiese cosa avessi in quella testa bacata, chi mi aveva autorizzato a farlo, che lì c’erano tutte le sue ossa. Balbettai che non lo sapevo, che credevo ci fossero solo trucioli e altri rimasugli inutili. Mormorò che ero un inutile moccioso e mi mollò un manrovescio che per poco non mi staccò la mandibola. Schiaffeggiarmi però stemperò la sua rabbia e aggiunse che dopo cena avrei dovuto dissotterrare il sacco.
Mangiavamo in silenzio. Nel frattempo si era scatenato un temporale implacabile. I lampi illuminavano la cucina e Marta sobbalzava a ogni rombo di tuono. Mi spiava, sentivo il suo sguardo addosso. La cercavo, ma lei lo distoglieva subito. Al sapore della minestra si mescolava quello nauseante del sangue. Ero ansioso, perché sapevo che Biagio presto o tardi mi avrebbe chiesto spiegazioni riguardo quella faccenda. Volevo solo andarmene a dormire.
Arrivò un tuono. Marta sussultò ancora dirigendo lo sguardo verso la finestra che dava sul giardino. Un secondo dopo fummo noi a sobbalzare udendo il suo grido: fuori dalla finestra c’era una sagoma. Schizzai in piedi. Mi avvicinai al vetro, tremante, e inorridii. Non credevo ai miei occhi. Nessuno di noi poteva crederci. C’era un uomo. Un uomo fradicio e imbrattato di fango, completamente nudo, identico a mio padre. Alle sue spalle, una fossa limacciosa che si dissetava col temporale.
Nato dalla terra, dalle ossa di mio padre. Eravamo sconvolti. Non sapevamo quale fosse la scelta giusta: se spaccargli il cranio o accoglierlo come un parente. Alla fine, lo accogliemmo, non avremmo potuto fare altrimenti. In fondo era un cristiano, proprio come noi. Mio padre lo osservava sconcertato, voleva buttarlo fuori a calci, farlo morire di freddo. Non era d’accordo con la nostra decisione. Bisognava agire come diceva lui, che era il capofamiglia, tuonava. Mia madre lo fece ragionare: quell’uomo, uguale a lui, non poteva andarsene in giro per il paese, sarebbe scoppiato uno scandalo. Dovevamo tenerlo nascosto. Papà capì e suo malgrado mandò giù il rospo. Quell’essere se ne stava in silenzio a fissarci. Lo sistemammo nella falegnameria, procurandogli un giaciglio, e lo chiudemmo dentro, così non sarebbe potuto scappare.
In realtà era docile, non parlava, e in tutta onestà aveva un’aria da idiota. Sembrava toccato. Questo però durò solo pochi giorni. Nessuno di noi seppe come, ma l’uomo cominciò ben presto a parlare e, osservandoci lavorare, imparò pure il mestiere. Biagio lo incoraggiava, gli spiegava la tecnica dell’intarsio e lui l’ascoltava con vivo interesse. Era a dir poco stupefacente apprendeva con incredibile rapidità. L’arte della falegnameria lo appassionava, come se fosse divenuto lo scopo della sua esistenza. Era preciso e pulito, possedeva gusto e creatività innati. Perfino mio padre dovette riconoscerlo, quanto meno a se stesso. Decise di metterlo a lavorare seriamente, sostenendo che così si sarebbe guadagnato il pane. Tuttavia lo denigrava, gli dava ordini come a un cane e lo picchiava per le ragioni più futili o se non eseguiva in fretta un suo comando. L’altro sopportava, limitandosi a mandargli ogni volta uno sguardo smarrito, chinandolo subito dopo.
Mio padre non aveva smesso di odiarlo, ma più di tutti odiava me, ritendendomi il responsabile di quella stregoneria. Non mi guardava in faccia e le uniche parole che mi rivolgeva erano solo comandi. Io tacevo, così come mia madre: mai avremmo rivelato che era stata Marta a sotterrare le ossa. Fu lei stessa a dare un nome all’uomo. Gli chiese se voleva essere chiamato Ettore e quello rispose di sì, che gli piaceva.
In certi momenti Ettore mi sembrava un bambino. Giocava con Marta, sotto lo sguardo intenerito di mia madre. Per quel suo modo di fare mio padre invece lo considerava ancora più stupido di quanto avesse immaginato. Non pareva impensierito, almeno apertamente, dal legame che Marta aveva stretto con Ettore. Al contrario, a me sembrava bizzarro e innaturale. Sbagliato. Ettore era gentile con tutti noi, all’apparenza incapace di far del male a una mosca, eppure mi infondeva una profonda inquietudine che faticavo a placare. Temevo potesse approfittare di mia sorella o di mamma.
Un giorno, uscito dalla falegnameria, lo vidi nel giardino che teneva Marta sulle sue ginocchia. Bisbigliavano, ogni tanto lei rideva. Sono sicuro di aver udito mia sorella chiamare Ettore papà. Non lo confessai a nessuno, nemmeno a Biagio.
La mattina dopo trovammo mio padre già in falegnameria. Si stava segando la falange dell’anulare. Bofonchiava bestemmie. Sul suo viso stava incastonata la frustrazione, il dolore a stento trattenuto. Quell’osso acuminato se lo infilò in tasca, e si mise a lavoro. Noi facemmo lo stesso, senza fiatare.
Poco dopo sentii mio padre sbraitare: posò la raspa per la limatura sul tavolo a cui stava lavorando. Chiamò Ettore, che stava intarsiando l’anta di un armadio, e gli ordinò di occuparsi della limatura al posto suo. Ma Ettore lo ignorò, seguitò a scavare il legno, tutto concentrato. Papà si spazientì e ripeté a gran voce, ma ancora una volta l’uomo non gli diede retta. Interdetti, io e mio fratello ci scambiammo un’occhiata. Biagio si azzardò a proporsi per quel lavoro, ma mio padre gli rispose di non immischiarsi e di chiudere la bocca. Papà insistette, Ettore invece pareva sordo. Gli afferrò il braccio per costringerlo a eseguire il compito. Ettore sollevò uno sguardo vuoto, imperturbabile, e disse di lasciarlo in pace. Papà s’infiammò all’istante, cavò dalla tasca il suo osso aguzzo e lo premette appena contro la gola di Ettore, che restò immobile. Biagio avanzò verso di loro e papà, senza staccare i folli occhi dal suo clone, lo intimò di non avvicinarsi oltre, altrimenti sarebbero stati guai anche per lui. Io stringevo tremante il punteruolo. Papà schiumava. Minacciò Ettore: se non gli avesse obbedito lo avrebbe scannato come un porco. L’uomo era una statua di sale. Un’assurdità: mi sembrava come se mio padre volesse uccidere se stesso. Ettore si sciolse. Con una calma agghiacciante gli prese il polso per allontanare l’osso dalla propria gola e si rimise a lavoro. Sbigottito, mio padre tornò in silenzio al tavolo e ricominciò con la limatura.
Lavoravamo muti, ognuno immerso nelle proprie riflessioni. Nella mia testa però risuonavano solo i colpetti del martelletto sullo scalpello.
Da quel giorno le condizioni di mio padre inaspettatamente precipitarono. La crescita delle ossa divenne incontrollata. Più venivano accorciate più quelle crescevano dense e pesanti. Affioravano in contemporanea su diversi punti del corpo. Ricordava un istrice. La febbre era sempre alta, non accennava a scendere, lo debilitava costringendolo a letto, e in breve tempo non poté più muoversi da lì.
Venne il dottor Tassi che lo visitò e, grattandosi la testa calva, biascicò che avrebbe trovato una soluzione. Prima di andarsene volle qualche nuovo campione delle ossa da visionare, per scoprire se ci fossero state delle anomalie, disse.
Quando entravamo in camera da letto, sotto i nostri piedi criccavano schegge d’ossa. Ci ritrovavamo le suole delle scarpe colme di frammenti.
Mamma si prendeva cura di papà tutto il giorno. In silenzio e impalata sulla soglia della stanza, Marta lo osservava per un po’, poi scappava via e andava subito a cercare Ettore per rifugiarsi nelle sue braccia. Se mi avvicinavo troppo al letto, mio padre si riscuoteva dal torpore, strabuzzava gli occhi e per pochi istanti ritrovava il vigore per cacciarmi a male parole. Dovevo sparire dalla sua vista. E io, gli obbedivo.
Ettore disse a me e Biagio che nonostante quella triste circostanza, il lavoro non doveva fermarsi. Concordi, riprendemmo a lavorare sotto la sua direzione. Eravamo spediti. Ettore e Biagio si scambiavano opinioni su come decorare i mobili e il risultato finale era sempre strabiliante. Quando terminammo tutta la mobilia, l’avvocato ci pagò più del dovuto dicendosi estremamente soddisfatto. Non si accorse nemmeno che l’uomo di fronte a lui non era mio padre.
Stetti a riflettere a lungo. Ettore e papà erano due gocce d’acqua, sulla pelle avevano perfino gli stessi nei, lo stesso timbro di voce. Tra loro due esisteva una sola differenza: Ettore era sano, non aveva mai manifestato i sintomi di quella malattia. Ma forse, pensai, era Ettore stesso la malattia, un male di cui il corpo di mio padre tentava di liberarsi, ma che invece si era fatto carne, e di nuovo ossa.
Assistere papà logorava e mortificava mia madre. L’aveva sfibrata fin dentro lo spirito. Era scheletrica e non dormiva più. I suoi lamenti la tenevano sveglia tutta la notte. Aveva bisogno di riposo, di rimettersi in sesto per accudirlo. Fu Ettore a trovare la soluzione: avremmo spostato papà in cantina. Biagio disse a mia madre che per un po’ si sarebbe occupato lui stesso di tenerlo d’occhio.
Lo sistemammo su una branda, in quel buco buio e ammuffito.
Mio padre non avrebbe potuto opporsi a quella decisione: il morbo lo stava annientando. Aveva la febbre altissima, non parlava, galleggiava in una sorta di veglia. A volte pensavo ci percepisse come ombre che gli gravitavano attorno, le nostre voci simili a un’eco indistinguibile.
Le ossa crescevano a dismisura. Aveva i gomiti lunghi e appuntiti, le costole fluttuanti, le vertebre esposte, come quelle di un rettile. Gli era spuntata di nuovo la coda, che aveva tanto divertito Marta. Biagio sosteneva che era ormai inutile continuare a segargli le ossa. Confidava che il dottor Tassi avrebbe trovato un rimedio, ma sapevamo che non ci sarebbe mai riuscito. Continuarono a crescere libere, attorcigliandosi su loro stesse.
Una mattina vidi Ettore uscire dalla camera da letto di mia madre. Ci scambiammo uno sguardo prolungato. Quando entrai in falegnameria il suo giaciglio non c’era più.
Se ne erano dimenticati, di mio padre. Lavoravano, mangiavano e scherzavano senza batter ciglio. Come se tutto fosse cambiato in meglio. Ed era vero. Non si avvertiva più quella tensione che aveva impregnato la nostra casa e la falegnameria. Era sparita. Io però vivevo un patema che mi toglieva il sonno. Non riuscivo ad ignorarlo. Allora scendevo giù in cantina, immergendomi nella penombra, e mi prendevo cura come potevo di quell’uomo che mi odiava con tutto se stesso. Emanava una puzza insopportabile. Aveva piaghe da decubito, e alla base delle ossa, intorno alla pelle e alle carni lacerate, c’erano incrostazioni e grumi di sangue. Lo udivo respirare a malapena. Un sibilo sbuffava fra gli interstizi dei suoi denti che parevano ormai zanne, ma non di un animale, bensì di una creatura mostruosa e indefinibile. Lo nutrivo, gli ponevo impacchi freddi sulla fronte, sporgente oltre ogni misura umana, per fargli abbassare la febbre, anche se erano premure vane. Una sera però papà raccolse le forze per stringermi piano la mano, e non ne sono certo, perché proprio la fronte gli schiacciava e copriva quasi del tutto gli occhi, ma ebbi la sensazione che avesse pianto.
Quando risalivo la cantina, sentivo sempre gli altri mormorare. Se mi vedevano si voltavano turbati e di colpo tacevano. A tratti mi fissavano e io non potevo reggere troppo a lungo quei loro sguardi indecifrabili.
Fu Biagio a svegliarmi una notte scuotendomi la spalla. Un’ombra gli tagliava in due la faccia. Mi disse di seguirlo e lo feci. All’ingresso della cantina stavano, strette l’una vicino all’altra, mia madre e Marta, che mi lanciarono una rapida occhiata.
Mi fermai e mio fratello stette a soppesare in silenzio la mia indecisione. Avvertii un’angoscia improvvisa e un terrore che mi pietrificarono. Biagio mi diede una leggera spinta sollecitandomi a scendere di sotto.
Fui subito investito da un terribile fetore. Accanto al letto, illuminata dalla lampada ad olio, si stagliava la sagoma di Ettore. Disse che avrei dovuto dare una mano per portare mio padre di sopra. Non gli chiesi il motivo. Al tre lo issammo insieme, facendo una fatica immane, perché le ossa erano pesantissime. La scalinata scricchiolava. Sudavamo. Ettore ordinò a mia madre di aprirci la porta.
Costeggiammo la casa e andammo tutti in giardino, dove vidi una profonda fossa che era stata senz’altro scavata da poco. Allora capii e mollai la presa. Ettore e Biagio si sbilanciarono e posarono papà sull’erba. Io lo fissavo cercando di intuire se era ancora vivo.
Biagio mi osservava disorientato. Marta si nascondeva dietro la sottana di mia madre.
Ettore si asciugò la fronte. La sua bocca soffiava sbuffi candidi. Mi venne incontro e pretese di esser guardato negli occhi. Esitando, obbedii. Mi domandò se facevo parte della famiglia. Abbassai lo sguardo. Stavo zitto, avevo un turbinio in testa, lasciavo vagare gli occhi tra la fossa e quel mostro sdraiato per terra. Ettore mi prese il volto tra le mani e ripeté la domanda. La gelida quiete che spandeva il suo sguardo mi indusse a rispondergli di sì. Lui mi diede una pacca sulla spalla, dopodiché si avvicinò a mio padre, Biagio e io lo imitammo, e al suo tre lo issammo un’altra volta. Il gemito di papà giunse distintamente, sono sicuro che anche la mia famiglia lo udì.
Lo gettammo nella fossa. Un tonfo tremendo che ci scosse. Ettore fu il primo a cominciare a riempirla di terra. Ognuno di noi aveva una pala, perfino Marta. Il mostro svaniva poco a poco, sommerso dalla terra, soccombendo alla morte. In quella tomba non stavamo solo seppellendo mio padre. Laggiù provavamo a sotterrare la nostra colpa. In silenzio sigillavamo un patto segreto che ci avrebbe legato fino alla fine dei giorni.
Quando terminammo, Ettore appianò il terreno. Abbracciò mia madre, Biagio, baciò Marta. Dopo venne da me, mi avvolse fra le braccia e mi sussurrò all’orecchio che mi voleva bene. Tremando scavai dentro me e trovai la forza per abbracciare il mio nuovo padre.
Matteo Romano è nato nel 1989 ad Altamura (Ba), ma ha sempre vissuto a Matera. Conseguita la maturità, si trasferisce a Parma per studiare giurisprudenza, facoltà che abbandona a pochi esami dalla laurea. Ha pubblicato il romanzo “Le porte” (Nolica Edizioni-CartaCanta) e racconti su Blam, Malgrado le mosche, Grado Zero, Bomarscé, Spore, Quaerere, Salmace, Offline, Nido di gazza, L’Appeso, Super Tramps Club e Gelo.
Immagine: iacopx_art
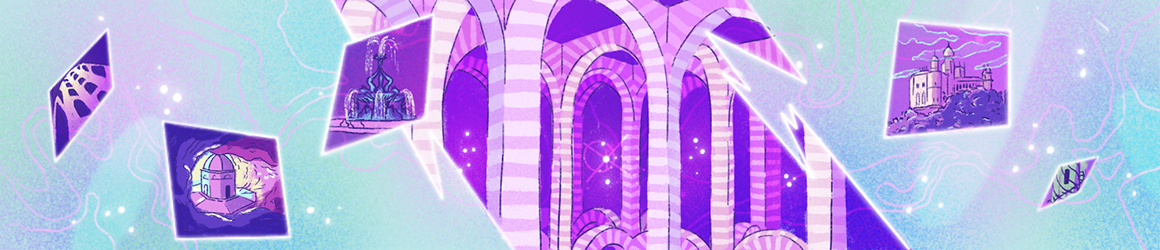

Nel racconto trovano spazio il grottesco e le questioni più intime e introspettive della vita quotidiana, in pieno stile dell’autore. È impossibile non inorridire davanti all’immagine mentale del padre deformato dalla sua malattia, o davanti all’immagine di un uomo nudo e coperto di fango che si affaccia alla finestra della nostra cucina in una notte buia e piovosa. Ed è altrettanto impossibile non lasciarsi intenerire dall’innocenza di Marta nell’affrontare e interpretare la malattia del padre, o dalle premure del protagonista nei confronti della sorellina (si tratta solo di alcuni elementi principali, il racconto è molto più ricco). Vediamo un’inversione di quello che è il classico concetto del doppelgänger: se quest’ultimo è abitualmente la controparte negativa, maligna di un personaggio principale positivo, in questo caso le caratteristiche si invertono e la controparte positiva prende il posto del personaggio principale negativo. Soddisfacente il finale, perfetta conclusione di un crescendo di situazioni negative e che sembra finalmente portare pace e tranquillità nella vita di questa famiglia. Ma sarà davvero così? L’uomo pacato, premuroso e apparente sano sarà davvero chi dice di essere? Vari elementi, tra cui la sensazione di inquietudine del protagonista nei confronti del gemello, non presagiscono nulla di buono. Sarebbe interessante approfondire la questione, così come approfondire la psicologia di alcuni personaggi come Biagio o la madre e approfondire ulteriormente quella del protagonista. Nel complesso bel racconto, appassionante e originale.
"Mi piace""Mi piace"
MD
"Mi piace""Mi piace"
coinvolgente..potrebbe essere una storia originale per un film di genere fantastico-horror..
"Mi piace""Mi piace"